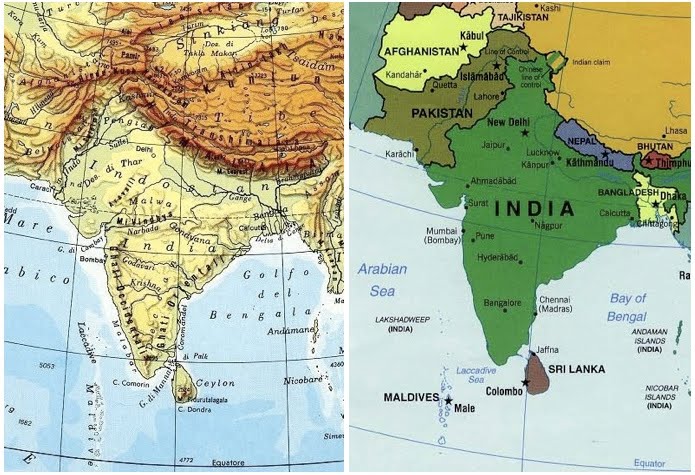Secondo un rapporto diffuso oggi da Amnesty International, dal titolo "C'è una pallottola per te", i giornalisti del Pakistan vivono sotto la costante minaccia di omicidi, intimidazioni e atti di violenza da parte di servizi segreti, partiti politici e gruppi armati come i talebani. Le autorità non fanno praticamente nulla per fermare le violazioni dei diritti umani contro gli operatori dell'informazione e per portare i responsabili di fronte alla giustizia.
Dal ritorno a un sistema democratico, nel 2008, Amnesty International ha registrato 34 casi di giornalisti assassinati a causa del loro lavoro; solo in un caso gli autori sono stati identificati e sottoposti a processi.
Ma questo è solo il dato più brutale. Nello stesso periodo, molti altri giornalisti sono stati minacciati, intimiditi, sequestrati, torturati o sono scampati a tentativi di omicidio.
"La comunità dei giornalisti del Pakistan è a tutti gli effetti sotto assedio. Soprattutto coloro che si occupano di sicurezza o di diritti umani vengono presi di mira da tutte le parti, nel tentativo di ridurli al silenzio" - ha dichiarato David Griffiths, vicedirettore del Programma Asia - Pacifico di Amnesty International.
"Le costanti minacce li pongono in una situazione impossibile, in cui ogni storia che raccontano li espone alla violenza da una parte o dall'altra".
Il rapporto odierno di Amnesty International si basa su un'ampia ricerca sul campo su oltre 70 casi e su interviste con più di 100 operatori dell'informazione.
Numerosi giornalisti intervistati da Amnesty International hanno segnalato intimidazioni o attacchi da parte di soggetti ritenuti legati alla temuta direzione dei servizi segreti militari (Isi). Alcuni di essi hanno accettato di raccontare la loro storia sotto falso nome, mentre altre storie sono state omesse dal rapporto nel timore che neanche uno pseudonimo li avrebbe tenuti al riparo da minacce alla loro vita.
L'Isi è stata implicata in numerosi rapimenti, torture e uccisioni di giornalisti, ma nessun agente in servizio è stato mai chiamato a risponderne. Ciò ha consentito ai servizi segreti di agire al di là della legge. Le violazioni dei diritti umani ad opera dell'Isi seguono un modello ricorrente, che inizia con telefonate minatorie e prosegue con sequestri, torture e altri maltrattamenti e, in alcuni casi, l'uccisione dell'ostaggio.
I giornalisti subiscono attacchi anche da parte di attori non statali. L'agguerrita competizione per trovare spazio sugli organi d'informazione comporta che potenti esponenti politici esercitino forti pressioni per avere una copertura stampa favorevole. A Karachi, i sostenitori del Movimento muttahida qaumi e del gruppo religioso Ahle Sunnat Wal Jamaat sono accusati di atti d'intimidazione e anche omicidi nei confronti di giornalisti.
Nelle zone di conflitto del nordest del Pakistan come nella regione del Balucistan, i talebani, il gruppo armato lashkar-e-jhangvi e i gruppi armati baluci minacciano apertamente di morte i giornalisti e li attaccano quando denunciano i loro abusi o non promuovono la loro ideologia. Anche nel Punjab, i giornalisti vanno incontro a minacce da parte dei talebani e dei gruppi collegati a lashkar e-jhangvi.
Nonostante questa ondata di violenza e attacchi, le autorità pakistane hanno ampiamente mancato di assicurare alla giustizia i responsabili. Nella stragrande maggioranza dei casi su cui Amnesty International ha svolto ricerche, raramente le autorità hanno svolto indagini adeguate sulle minacce e gli attacchi o portato i responsabili in un'aula di tribunale.
Solo in una manciata di casi di alto profilo e quando l'oltraggio dell'opinione pubblica non ha reso possibile agire diversamente, le autorità hanno svolto indagini più approfondite.
"Il governo ha promesso di migliorare questa terribile situazione, anche attraverso l'istituzione di un procuratore incaricato delle indagini sugli attacchi contro i giornalisti, ma di concreto è stato fatto poco" - ha commentato Griffiths.
"Una misura determinante sarebbe quella d'indagare sulle agenzie militari e d'intelligence assicurando così i procedimenti giudiziari nei confronti dei responsabili. Coloro che prendono di mira i giornalisti saprebbero in questo modo di non poter più agire impunemente" - ha aggiunto Griffiths.
I proprietari dei mezzi d'informazione a loro volta dovrebbero assicurare formazione adeguata, sostegno e assistenza ai giornalisti, per meglio valutare e affrontare i rischi collegati al loro lavoro.
"Senza questi provvedimenti urgenti, gli operatori dell'informazione del Pakistan rischiano di essere ridotti al silenzio. Questo clima di paura ha già avuto un effetto raggelante sulla libertà d'espressione e sul più ampio tentativo di denunciare le violazioni dei diritti umani nel paese" - ha concluso Griffiths.